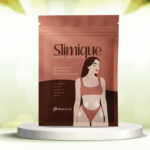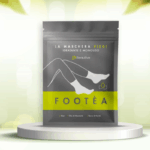Il patrimonio degli italiani varia profondamente a seconda dell’età, riflettendo cambiamenti storici, socio-economici e dinamiche intergenerazionali che hanno definito la distribuzione della ricchezza nel paese. I dati più recenti confermano come la fascia di popolazione più anziana resti nettamente più benestante rispetto alle generazioni più giovani, con tendenze che accentuano il divario tra chi ha avuto tempo e condizioni favorevoli per accumulare ricchezza e chi si trova oggi, spesso precariamente, agli inizi del proprio percorso lavorativo e patrimoniale.
Patrimonio netto e distribuzione per fasce d’età
La crescita della ricchezza netta familiare in Italia segue un andamento tipico: aumenta con l’avanzare dell’età e raggiunge il suo massimo fra i 55 e i 74 anni, per poi decrescere leggermente tra gli ultra75enni. Nel dettaglio, secondo l’ultimo rapporto Censis-AIPB, le famiglie il cui capofamiglia ha tra i 55 e i 64 anni possiedono il valore mediano più alto di ricchezza finanziaria. Tale valore si attesta a circa cinque volte superiore rispetto a quello delle giovani famiglie sotto i 35 anni. La forbice si è ulteriormente dilatata rispetto a inizio Duemila, segno che gli under 35 hanno oggi minori possibilità di accumulare patrimonio rispetto alle generazioni precedenti, a causa di precarietà lavorativa e difficoltà di accesso alla casa e al credito.
Ecco una fotografia schematica della ricchezza per età sulla base delle ultime analisi disponibili:
- Sotto i 35 anni: patrimonio finanziario mediano estremamente ridotto, incidendo negativamente anche sulla possibilità di investire o acquistare beni durevoli.
- 35-44 anni: lieve incremento, ma il livello resta distante da quello registrato tra 15 e 20 anni fa per la stessa fascia.
- 45-54 anni: il valore mediano si colloca attorno ai 6.000 euro di ricchezza finanziaria, ma con fortissime differenze interne tra famiglie “stabilizzate” e quelle ancora precarie.
- 55-64 e 65-74 anni: qui la ricchezza tocca i massimi, frutto di decenni di accumulo, spesso grazie anche a investimenti immobiliari e rendite da risparmio.
- Oltre 75 anni: si evidenzia una leggera decrescita dovuta a consumi per assistenza e salute, ma i livelli restano elevati.
I grandi divari tra generazioni e il peso delle eredità
Le attuali statistiche consolidano l’immagine di una società italiana altamente diseguale, dove la ricchezza si concentra soprattutto nelle mani degli anziani e dei ceti più abbienti. Il 5% più ricco delle famiglie italiane detiene quasi la metà della ricchezza nazionale. All’interno di questo gruppo, lo 0,1% più ricco ha visto il proprio patrimonio crescere ininterrottamente dagli anni ’90 a oggi, con incrementi superiori al 70%. Quasi due terzi di queste somme derivano da eredità, segnalando come il passaggio generazionale del patrimonio sia un fattore decisivo, molto più rilevante che in altri grandi paesi. Le nuove generazioni, spesso prive di consistenti lasciti familiari o immobilizzate in lavori precari, faticano ad accedere agli stessi livelli di sicurezza economica dei genitori e dei nonni.
Si prevede che i prossimi decenni saranno caratterizzati dal più grande trasferimento di ricchezza dal dopoguerra: il patrimonio concentrato nelle mani della generazione dei baby boomer (nati tra il 1946 e il 1964) passerà gradualmente a figli e nipoti. Questo passaggio rappresenterà una delle principali variabili di ridisegno della distribuzione della ricchezza nazionale. Il tema delle eredità sarà quindi centrale sia per motivi demografici che sociali, con potenziali impatti sui consumi, sugli investimenti e sulle possibilità per i giovani di entrare nel mercato immobiliare o imprenditoriale.
Il confronto con gli altri paesi e il ruolo della proprietà immobiliare
La struttura patrimoniale degli italiani mostra alcune peculiarità rispetto alle economie avanzate. In Italia, la quota di ricchezza detenuta sotto forma di immobili è particolarmente elevata: la proprietà della casa resta un pilastro del benessere familiare, soprattutto tra gli over 55. Questo aspetto protegge le famiglie dalla volatilità dei mercati finanziari, ma può penalizzare i giovani, che spesso affrontano prezzi elevati, stipendi stagnanti e difficoltà di accesso ai mutui.
Se si osservano i dati internazionali, ad esempio quelli riportati dalla Federal Reserve per gli Stati Uniti e pubblicati da Plisio.net, si nota che anche lì il patrimonio netto cresce con l’età: la ricchezza media passa da circa 183.500 dollari per i giovani sotto i 35 anni a quasi 1,8 milioni per la fascia tra 65 e 74 anni. Tuttavia, in Italia il fenomeno appare più polarizzato, con le nuove generazioni bloccate in posizioni di stratificazione sociale sempre più difficili da scalare.
Prospettive future e impatto sulle nuove generazioni
L’invecchiamento demografico e la crescente centralità delle eredità nella formazione del patrimonio personale pongono l’Italia davanti a nuove sfide sociali ed economiche. I giovani trovano molte più difficoltà degli anni Novanta nell’accumulare anche piccoli patrimoni, e ciò li rende più esposti a rischi finanziari e meno propensi all’investimento a lungo termine. La possibile “trappola patrimoniale” rischia di diventare strutturale, con impatti sulla mobilità sociale e sull’innovazione del sistema economico.
Affidarsi al sistema pensionistico o ai risparmi di famiglia non è più una certezza per i Millennials e la Generazione Z, viste le incertezze del welfare pubblico e la differente struttura del mercato del lavoro. Il rafforzamento dell’educazione finanziaria, la promozione del risparmio previdenziale e misure di sostegno all’imprenditorialità giovanile saranno strategie centrali per evitare che il gap patrimoniale si trasformi in nuove fonti di esclusione sociale.
In sintesi, la ricchezza degli italiani cresce con l’età, raggiunge il picco con la maturità e si mantiene relativamente alta anche negli anni della vecchiaia; tuttavia, questo modello di accumulazione patrimoniale rischia di non essere più riproducibile per le nuove generazioni, con implicazioni potenzialmente dirompenti per l’equilibrio sociale del paese.